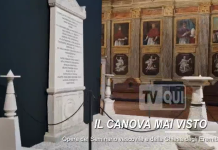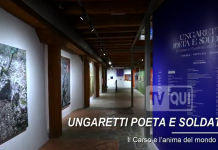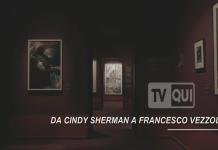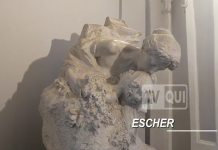Breve storia della nostra biblioteca Anche sul fronte dei libri, come già su quello dei dipinti, degli affreschi, delle sculture, delle medaglie e dei gioielli, le raccolte estensi nulla ebbero da invidiare a quelle medicee e gonzaghesche. Quando nel 1436 per volontà del marchese Nicolò III dEste, promotore dellUmanesimo entro i confini dello stato mediante i precettori dei suoi molti figli, venne redatto il primo inventario dei codici e dei libri affastellati in una sala della Torre di Rigobello, adiacente alla merlata dimora marchionale, numerosi furono i volumi registrati databili a epoche e secoli precedenti, e valga per tutti limmensa fortuna trecentesca che anche presso la corte di Ferrara avevano avuto le opere di Dante Alighieri, di Giovanni Boccaccio e di Francesco Petrarca. Laver acceso in tutti i suoi rampolli, e specialmente nei suoi eredi e successori, linteresse per le humanae litterae e per la riscoperta della classicità valse a Nicolò un titolo di gloria oltre che di intelligente lungimiranza. Lui e la moglie Parisina avevano, sì, incrementato la biblioteca di palazzo con pregevoli opere della tradizione arturiana e francese, con le liriche trobadoriche in lingua doc (lingua provenzale) e i cicli carolingi in lingua doïl (lingua franca), lei in particolare facendo restaurare un antico esemplare del Romanzo di Tristano vergato su pergamena e illustrato a penna da un artista di corte rimasto anonimo, e comperando senza posa i titoli cavallereschi più in voga allepoca. Ma limpulso di novità dato dai principi Leonello e Borso fu impareggiabile. Luno, rimasto nel titolo ufficiale semplicemente marchese ma in realtà sovrano assoluto dellambiente dello studiolo umanistico nel quale alla lettura assorta faceva da unica compagna la conversazione trascelta e colta, divenne addirittura il modello del principe ideale del Rinascimento anche sulla scorta delle sue collezioni librarie in cui figuravano, tra gli altri, i libri eruditissimi di Leon Battista Alberti rilegati in preziosi esemplari di dedica al signore. E cioè ancor più elitari ed eletti di un semplice manoscritto, già di per sé irripetibile e ineguagliabile. Laltro, primo duca della casata, dominus sontuoso e pater patriae con qualche velleità militare, viene ancora e sempre (e quasi naturalmente) associato alla sua maggiore e grandiosa impresa di bibliofilo, la Bibbia in due volumi che è oggi il cimelio della Biblioteca Estense, il volume simbolo dellintera collezione così come il Busto berniniano di Francesco I lo è per la soprastante Galleria. Conservata in una teca blindata a temperatura costante ed esposta al pubblico solo in occasioni speciali, questopera fu al tempo della sua realizzazione, il 1456, lanno stesso delluscita della prima Bibbia a stampa di Johann Gutenberg, il manifesto delladesione convinta del duca DEste alla raffinata e costosissima produzione manoscritta, ovvero il manifesto del suo radicale rifiuto del libro stampato, subito avvertito come un ordinario libro in serie. Ciò, ovviamente, non impedì a Borso di avere sui suoi scaffali privati libri a stampa a volontà, che pure egli negava di possedere e di maneggiare per non venir meno alla sua fama di principe del Quattrocento. Ciò non impedì poi ai migliori intellettuali circolanti per la corte ferrarese, come Pietro Bembo, di collaborare attivamente con la stamperia veneziana di Aldo Manuzio, e agli agenti ducali di comperare incunaboli e cinquecentine che nei secoli andarono a costituire altre sezioni preziose della Ducal Libreria, come venne chiamata in origine. Ma limpegno dinastico a tener vivo lo scriptorium ferrarese non venne mai meno nei diretti successori di Borso, Ercole I e Alfonso I dEste, ai quali dobbiamo rispettivamente opere uniche quali il Breviario e lOfficiolo Alfonsino, il primo rientrato a Modena nel 1939, il secondo smembrato in due frammenti e conservato tra Zagabria e Lisbona. Realizzato tra il 1505 e il 1510, il libro dore di Alfonso I fu lultimo grande codice religioso a essere realizzato in forma esclusivamente manoscritta e miniata. Dopodiché, che al duca Borso (ormai buonanima) piacesse o no, anche allinterno della biblioteca degli Este il libro a stampa ebbe totale sopravvento e definitiva vittoria. La produzione libraria della Cappella musicale fu, dal canto suo, allaltezza di quella dei signori e della corte e i grandi codici di polifonia sacra vergati e decorati nellepoca rinascimentale di Borso e dei suoi discendenti fanno ancora bella mostra di sé tra lEstense di Modena e la delizia ferrarese di Schifanoia. Ma proprio al fondo musicale estense, che avrà ancora modo di arricchirsi favolosamente nel Seicento, diede un eccezionale contributo la composizione dei madrigali per lesclusivo, quasi misterioso, Concerto delle Dame Principalissime del duca Alfonso II e della sua terza consorte, Margherita Gonzaga. Questo sovrano, lultimo del ramo principale della dinastia, lultimo a poter conservare il vicariato di matrice pontificia sullamata città di Ferrara, fu talmente geloso dei testi elaborati da Battista Guarini e Luzzasco Luzzaschi per le sue quattro talentuosissime virtuose, Tarquinia Molza (voce), Laura Peperara (arpa), Livia dArco (liuto) e Anna Guarini (viola da gamba), da impedirne la pubblicazione e quindi la circolazione per le corti dItalia e dEuropa. Con un doppio risultato: che allepoca (1580-1590) il Concerto divenne un fenomeno culturale tanto riservato e segreto quanto ambito, e che nella biblioteca di corte finirono spartiti inediti preziosissimi che tutto il mondo avrebbe voluto sentir suonare e cantare. Alfonso II, non dimentico della tradizione libraria di famiglia, fece poi un ultimo, estremo omaggio alla raccolta dei codici antichi della Casa DEste comperando sul mercato del tardo Cinquecento, e per abile intermediazione del suo agente Girolamo Falletti, i manoscritti quattrocenteschi miniati nel laboratorio fiorentino di Attavante degli Attavanti per il re dUngheria Mattia Corvino, lontano parente dei suoi antenati. La Biblioteca arriva a Modena Linguaribile cesura politica, geografica e dinastica che si verificò con la morte di Alfonso II (1597) e la conseguente Devoluzione di Ferrara alla Santa Sede (1598) causò inevitabilmente qualche perdita anche tra i libri, giacché il trasferimento dei beni del casato dalle numerose dimore di Ferrara al castello di Modena fu colossale e si protrasse per decenni. Ma limmensa collezione giunse tutto sommato integra se non proprio intatta, e negli anni Quaranta del Seicento essa trovò adeguata collocazione dentro le prime ampie sale attrezzate con eleganti scaffali lignei del novello Palazzo Ducale voluto da Francesco I, disegnato dallarchitetto romano Bartolomeo Avanzini e allepoca ancora in costruzione. Lì, oltre ai libri, vennero ordinate ed esposte le anticaglie e le curiosità naturali che già preludevano a una ricca Wunderkammer. Il maggior lascito librario di Francesco I consistette in unopera a stampa pubblicata da Bartolomeo Soliani due anni dopo la morte del sovrano, nel 1660, Lidea di un Prencipe et Eroe Christiano in Francesco I dEste, un imponente volume esequiale nel quale vengono ripercorse le virtù religiose, morali e politiche del sovrano ereditate dagli avi ferraresi e ne viene raccontato il quotidiano e infaticabile lavoro di duca attraverso una serie di scenette teatrali in cui il sipario si apre sui suoi gesti solenni, sul suo abbigliamento fregiato delle insegne del comando, sulle, imprese, le opere e i cantieri da lui voluti e finanziati. Un libro grandioso tanto quanto il suo protagonista, e che a quasi quattro secoli di distanza ci consente di immergerci per parole e immagini nel tempo altamente scenografico e cerimoniale del Seicento. Leffettiva erede dello scettro di Francesco, Laura Martinozzi, nipote del cardinale Giulio Mazarino, vedova di Alfonso IV e reggente per il piccolo Francesco II dal 1662 al 1674, non incrementò significativamente la biblioteca, essendo lei più che altro preoccupata a risparmiare sul fronte ducale e a spendere (ma furono per lo più denari personali e dotali) su quello religioso, ovvero a rifornire di reliquie santissime, di manufatti darte e di libri preziosi il monastero da lei fondato delle monache della Visitazione. Sotto il governo di Laura, la temuta Duchessa Padrona, accadde tuttavia qualcosa di importante che ancora prosegue ai giorni nostri: la biblioteca della famiglia, della corte e del Palazzo divenne nel 1664 deposito di copie dobbligo di tutto ciò che veniva stampato entro i confini del territorio allora ducale, oggi provinciale. Una prerogativa, questa, che nei secoli lha riempita allinverosimile, ma che al contempo lha resa custode diretta e principale delleditoria locale e di tutte le sue pubblicazioni. Con Francesco II, che dopo lepoca sparagnina della madre riprese a scialacquare senza posa e sul modello degli antenati, si verificarono due fenomeni di segno opposto: da un lato, i suoi cugini prediletti, i tre ambiziosi Estensi che lo consigliavano nellesercizio del potere, poterono portar via dalla galleria dei capolavori dipinti in quantità alla volta delle rispettive residenze private; dallaltro, egli comperò di continuo disegni e spartiti per assecondare le sue più spiccate inclinazioni artistiche, la passione per la grafica e quella per la musica. La seconda, notevolissima e geniale, fece sì che Modena diventasse nel ventennio di governo di questo sovrano (1674-1694) una capitale europea dellarte di Euterpe e che allinterno della Ducal Libreria arrivassero opere e composizioni dei più celebri musicisti del secolo, tra i quali i fautori di uno strumento nuovo per quei tempi, il violoncello. Grazie al raffinato mecenatismo del duca «giunsero da Roma centinaia di manoscritti di cantate a voce sola, centinaia di partiture di oratorii che oggi rappresentano in assoluto la testimonianza più cospicua di questo genere devozionale, le decine e decine di volumi che raccolgono le arie delle opere in musica rappresentate nei principali teatri dItalia tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta del Seicento, infine il patrimonio di carte musicali del compositore Alessandro Stradella, acquisito e così salvato dal duca subito dopo la morte dellartista». Un fondo straordinario, che continua a richiamare presso la Biblioteca Estense studiosi e musicisti da tutto il mondo. Francesco III, salito al trono ducale nel 1737 dopo il padre, Rinaldo I, che per parte sua aveva affidato la direzione della biblioteca, della galleria e dellarchivio a Ludovico Antonio Muratori, promosse un nuovo allestimento della collezione dei capolavori darte disponendoli nelle sale di rappresentanza del Palazzo affacciate sullattuale piazza Roma insieme con i libri più illustri e con le medaglie. Lintento fu quello di valorizzare lintero patrimonio ducale, tra eredità ferraresi e incrementi modenesi, mostrandolo nella sua complessità sia quantitativa che qualitativa, e in effetti i visitatori e gli ospiti di quel periodo (anni Quaranta del Settecento) restavano senza fiato al cospetto di una raccolta ricchissima, ben ordinata e severamente custodita. Purtroppo la vendita di Dresda, ovvero la cessione di cento dipinti al re di Polonia dietro il pagamento di una sostanziosa somma di denaro, depauperò inevitabilmente lintero tesoro e quelle stanze spogliate dei Correggio e delle altre grandi firme del Rinascimento e del Manierismo non furono più le stesse. Tuttavia, comera accaduto già sotto Francesco II, alluscita di numerosi quadri dalla collezione fece da contraltare lingresso di numerosissimi titoli nella biblioteca: la cospicua produzione editoriale dei circoli letterari, delle accademie, delle case editrici, delle gazzette cittadine e delle prime forme di giornalismo culturale andarono ad aumentare esponenzialmente la quantità di pagine e di volumi sugli scaffali della Ducale Libreria. Nel 1761 arrivò anche la svolta sociale con la sua apertura al pubblico voluta sempre da Francesco III, duca illuminista e per molti versi illuminato. LOttocento registrò una gran messe di acquisizioni. La soppressione degli ordini religiosi e conventuali, ora decretata dalletà dei lumi ora seguita alla discesa di Napoleone Bonaparte in Italia, provocò lincameramento da parte della biblioteca degli Este di consistenti e raffinate raccolte provenienti dai monasteri della città e del territorio ducale. A seguire, il duca restaurato Francesco IV dAustria Este, salito alla guida dello stato avito nel 1814, arricchì notevolmente la raccolta libraria, che anchegli lasciò di fruizione pubblica, con elargizioni proprie, in particolare con il prezioso lascito del conte Tommaso Obizzi del Cataio (che comprendeva codici miniati e codici liturgici olivetani) e con le ragguardevoli raccolte musicali e mitteleuropee di suo fratello, larciduca Massimiliano. Uscendo definitivamente da Modena l11 giugno 1859 alla volta dellesilio viennese sotto lala protettrice e familiare degli Asburgo, suo figlio, lultimo sovrano della dinastia, Francesco V, portò con sé quale supremo bene di famiglia la Bibbia di Borso dEste, a riprova che linsuperabile mecenatismo del Rinascimento ferrarese restava una cifra inconfondibile nella storia, anche la più drammatica, della dinastia. Il monumentale manoscritto in due volumi rientrò poi nelle collezioni modenesi nel 1923 per il generoso intervento del senatore Giovanni Treccani, che lo acquistò sul mercato antiquario e lo restituì con gesto tanto munifico quanto magnifico alle librerie a cui era da sempre appartenuto. Verso i nostri giorni Con la proclamazione del Regno dItalia, la biblioteca degli Este passò da istituzione ducale a istituzione regia e fu Celestino Cavedoni, allepoca ancora responsabile del patrimonio librario di matrice atestina, a seguirne la trasformazione formale e burocratica. Nel contesto postunitario e in seguito allestinguersi di alcune nobili dinastie modenesi i suoi scaffali cominciarono a riempirsi di abbondanti depositi familiari come quelli dei Campori, dei Ferrari Moreni e dei Bertoni, a cui si aggiunsero lArchivio Editoriale Formiggini e la personale raccolta di Albano Sorbelli. Ma il successivo e considerevole accrescimento fu determinato sul finire del secolo XIX dallunificazione della Biblioteca Estense con la Biblioteca Universitaria fondata nel 1772 da Francesco III e riaperta al pubblico da Francesco IV nel 1844 dopo la temperie napoleonica e i primi sussulti risorgimentali: i due enti vennero uniti nominalmente e fisicamente nel 1892, benché molto più tarda sia stata la loro assimilazione amministrativa e gestionale, sancita solo nel 1995 anche attraverso il nome ufficiale di Biblioteca Estense Universitaria. Impossibile, invece, la loro assimilazione dal punto di vista dei contenuti, così come la giustapposizione del nome ben riflette e compendia: lEstense, infatti, conserva inalterata la sua connotazione precipuamente storico-umanistica, principale eredità della storia e del patrimonio estensi, mentre lUniversitaria, a carattere prevalentemente scientifico, opera come sussidio, appunto, degli studi universitari, conservando essa stessa, come laltra, le funzioni avute fin dallorigine. Il che non inficia, al contrario arricchisce, la loro prestigiosa interdisciplinarità. Nel frattempo, e precisamente nel 1883, le collezioni dei libri estensi avevano seguito lo stesso destino delle collezioni darte dei sovrani decaduti ed esiliati, erano uscite, cioè, dal Palazzo Ducale trasformato in Scuola Militare di Fanteria e Cavalleria (e poi in Accademia Militare) e avevano trovato nuovo alloggio in quellAlbergo delle Arti divenuto più tardi lattuale Palazzo dei Musei. Lì furono raggiunte dalle collezioni universitarie.