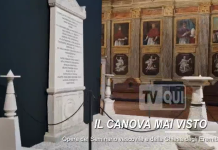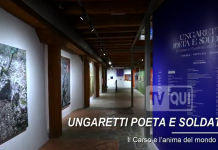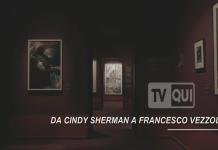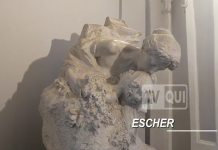«Da tempi immemorabili gli antenati di Luisa Elisabetta dOrléans sono soliti contrarre matrimonio tra loro: i suoi nonni (il re Luigi XIV, nonno materno, e Filippo dAngiò principe dOrléans, nonno paterno) sono fratelli, i suoi genitori sono cugini di primo grado, ogni singola cellula del suo corpo può essere considerata strettissima parente di quella che le sta accanto. Lendogamia perseverante genera problemi caratteristici, e così fu nel caso dei Borbone-Orléans. E nella regina di Spagna Luisa Elisabetta tali disordini genetici furono i meno indicati per una principessa destinata a regnare. Anche il ramo paterno (padre, nonno e nonna) mostrava una vetrina variopinta in fatto di squilibri. Allelenco non manca nulla: sconnessione sociale, impulsività, ipercompensazione narcisista, intolleranza, crudeltà, alcolismo, depravazione sessuale, violazione delle regole, eccentricità, istrionismo e assenza di empatia». Il brano è tratto dal bel libro di Alejandra Vallejo-Nágera, I pazzi della storia (ed. Nuovi Mondi Media, 2006) e illustra in modo molto efficace quali danni la pratica dellendogamia, ovvero delle nozze tra consanguinei, aveva arrecato alla famiglia regnante di Francia, e in modo particolare ai sette figli dellunico nipote di Luigi XIV, il duca Filippo dOrléans, figlio di suo fratello Filippo dAngiò e Reggente per Luigi XV dopo la morte dello zio, avvenuta nel 1715. Infatti il matrimonio decisamente endogamico tra il duca, perso indistintamente dietro crinoline e redingotes, e una sua cugina di primo grado, la principessa Maria Francesca di Borbone, figlia del Re Sole e della sua celebre amante Athénaïs de Montespan, aveva fatto letteralmente esplodere le bizzarrie e le perversioni già manifeste della dinastia, con la conseguenza che se tra i loro sette figli (cinque femmine e due maschi) la più psicolabile fu Luisa Elisabetta, capace di comportamenti incontrollati e osceni, nessuno tuttavia andò esente da turbe, capricci, stravaganze e serissimi disturbi della personalità. Ebbene, se dopo tutto ciò si considera che unaltra dei sette figli suddetti e delle cinque pazze sorelle fu proprio la duchessa di Modena Carlotta Aglae dOrléans (1700-1761), ben si capisce che razza di incontenibile tempesta arrivò nella quieta e sobria casa del duca Rinaldo I dEste allorché egli si incaponì a far sposare il suo erede Francesco (poi Francesco III) con quella bizzosa fanciulla parigina, pur di riallacciare con la corona doltralpe i rapporti diplomatici interrotti durante gli ultimi anni di regno di Luigi XIV. Unonda di piena che ruppe gli argini della Casa estense, travolgendo senza la minima delicatezza uomini, beni e sentimenti. Una lancia, però, va spezzata a favore di Carlotta Aglae madamigella di Valois. Ed è la lancia dellallegria. Perché pur essendo lei lunatica e balzana, senza tuttavia arrivare alle instabilità di sua sorella Luisa Elisabetta, non cè dubbio che i suoi modi portarono nella cupa corte modenese una ventata di novità e di buonumore apprezzata da molti. Intendiamoci: le liti frequenti con il duca, i tradimenti a danno del giovane marito, le tresche sentimentali con cognati e cortigiani, le continue pretese di denari, divertimenti e abiti nuovi non allietavano lambiente del Palazzo Ducale. Ma bastò darle sulle colline di Rivalta una villa degna di Versailles in cui potesse sbizzarrirsi tra cacce, feste e banchetti, e soprattutto bastò attendere che il severissimo Rinaldo andasse sottoterra, e anche la famiglia cambiò idea su di lei, trovando che ai tetri anni di rigore, di parsimonia e di preghiera fossero davvero preferibili le danze notturne, gli incontri damore furtivi, le lunghe partite al gioco del biribisso, i pranzi che si facevano cena e le cene che sconfinavano nella colazione mattutina. E senza che Carlotta fosse mai stanca di amare e di giocare, di giocare e di amare. Nel frattempo, nelle sue stanze di studio polverose e affastellate di carte, Ludovico Antonio Muratori conduceva unesistenza ben diversa, raccolta, contemplativa e integerrima, lesistenza intellettuale che aveva condiviso con Rinaldo I, forse lultima vera memoria di Rinaldo rimasta in corte di Modena. Quella di Carlotta fu, invece, unesistenza spensierata e spregiudicata. E malgrado a Modena lei proprio non volesse venirci Via da Parigi, via dalla vita La nonna paterna di Carlotta, la spietata madame Liselotte di Baviera, donna tutta dun pezzo, capace di reggere un marito strambo come il principe dAngiò, e crudelmente sincera comera nello stile tipicamente privo di empatia della famiglia reale francese, lo disse a chiare lettere al duca di Modena: mia nipote non è solo bugiarda, inaffidabile, scriteriata e ninfomane, è pure brutta. I ritratti di Carlotta, in verità, dicono altro. Anzi, quelli francesi della giovinezza dicono esattamente il contrario. Eppure la vecchia nobildonna sosteneva che la ragazza avesse un lungo dente canino che le sporgeva persino dalle labbra chiuse, un naso che tutto era fuorché delicato, e modi intollerabili che abbruttivano ancor più la sua malagrazia. Fatta la tara al pennello e alla volontà dellartista di turno di consegnare un ritratto piacevole e piacente, poté essere che Liselotte cercasse di salvare il duca di Modena, e Modena tutta, anche con un simile mezzo, la millantata bruttezza esteriore di una ragazza che bella dentro non era affatto. Ma Rinaldo, in nome della politica, schivò anche questo ostacolo e al figlio, che forse impallidiva davanti a tali notizie, imponeva la ragion di stato. Mentre al suo ministro Benedetto Selvatici, forse già sedotto a Parigi, durante le trattative nuziali, dalla libera impudenza della promessa sposa, e dunque favorevolissimo al partito, egli concedeva un credito illimitato, sollecitandolo a concludere e a sottoscrivere il patto matrimoniale. In breve, a condurre Carlotta a Modena. E che non se ne parlasse più. Lei sulle prime disse di no a tutto: ad andar moglie di un oscuro principe italico, a lasciare Parigi per trasferirsi in una corte piccola e provinciale, insomma a cambiar vita. Poi, tra una pressione e laltra, si dispose quantomeno a sposarsi in cambio di una cerimonia degna di unimperatrice. In cuor suo, però, Carlotta Aglae continuò a non dire sì a nulla. Non disse sì alla fedeltà, allonorabilità, alla dignità ducale, al marito, meno che mai a unintera vita modenese, e cioè alla promessa di non far più ritorno a Parigi. Aveva ragione sua nonna Liselotte, era una ragazza bugiarda. Ma come potevano pretendere da lei che lasciasse la reggia borbonica di Versailles, dove tutto era lecito, per la reggia estense di Sassuolo, dove tuttal più era lecito far villeggiatura? Le nozze ducali, ovvero mortali Il matrimonio per procura tra il principe ereditario del ducato di Modena e Reggio, Francesco dEste, e la figlia del Reggente di Francia, Carlotta Aglae dOrléans, fu celebrato in pompa magna nel Gabinetto Reale del Palazzo delle Tuileries (oggi perduto) il 12 febbraio 1720, alla presenza della corte al gran completo e con la benedizione del cardinale di Rohan, che officiò il rito. Era talmente felice, Carlotta, di quellanello al dito che prima di partire tentò pure di suicidarsi chiudendosi in un monastero dove infuriava un contagio spaventoso misto di vaiolo e rosolia. Ma nulla la salvò dallavventura modenese, nemmeno la morte. E così, nel giugno dello stesso anno, ella arrivò nella capitale estense imbronciata e indispettita come nessuno ricordava di aver mai visto arrivare una sposa novella. Ci avrebbe messo quindici anni esatti per riuscire a tornare a Parigi, quindici anni snervanti di permessi richiesti e puntualmente rifiutati, ma quindici anni infine trascorsi e finiti, dopo i quali i suoi soggiorni francesi divennero sempre più frequenti e prolungati. Anche gli amanti non si fece mancare, secondo la migliore consuetudine mondana che le aveva rovinato la reputazione fin dalla più giovane età: gli amanti veri, come lavvenente duca di Richelieu che la raggiunse di soppiatto fin nei suoi appartamenti modenesi sotto mentite spoglie; e gli amanti presunti (ma forse veri anche quelli), come tutti gli uomini di Casa DEste, dal conte Selvatici, perdutamente innamorato di lei, al bel cognato in armi Gian Federico, che così rovinò definitivamente il già difficile rapporto con il principe suo fratello, a molti altri ministri e cortigiani. Le feste, le giostre, le cacce, i ricevimenti, i balli, i minuetti, le carte da gioco e il gioco dazzardo furono poi allordine delle sue giornate, e specie dopo che Francesco III acconsentì ai costumi della consorte trovandovi lui stesso diletto, piacere, e infine pace. Nove i figli allattivo del loro talamo nuziale, alcuni morti senza neppure che la madre si prendesse lincomodo di tornare a Modena da Parigi per piangerli e seppellirli. A conferma che la disaffezione era sicuramente tra i disturbi ereditari della sua personalità. E prima di partire per uno dei suoi viaggi verso gli spassi francesi, Carlotta Aglae si prese pure una sfacciata rivalsa facendosi ritrarre da un artista di corte nelle vesti della casta Artemide, di quella Diana cacciatrice di cui aveva imitato gli svaghi venatori, ma non certo la pudica e incontaminata moralità. Non male farsi dipingere da vereconda dea lanciando a tutti il guanto di una sfida ironica e sorridente: la scommessa di riuscire a ricordarla come tale. Carlotta Aglae dOrléans morì nella sua Parigi il 19 gennaio 1761. Non le era mai importato nulla di essere la duchessa di Modena, perché anche a Modena le era importato solamente di vivere, vivere come meglio poteva, allaltezza dei suoi desideri e delle sue bizze. In tutti i ritratti di lei che ci sono rimasti il lungo dente canino descritto dalla nonna Liselotte non le spunta mai dalle labbra. Probabilmente, morto Rinaldo e stabilita con Francesco una buona intesa di coniugi fatta innanzitutto di divertimenti, non ebbe più bisogno di succhiare il sangue di nessuno.
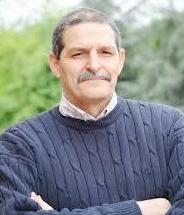
Una famiglia di pazzi: la volubile duchessa venuta da Parigi
1423